Abstract
«A History of Industrial Hygiene: the Clinica del Lavoro in Milan and the Italian Association of Industrial Hygienists». In 1969, the Italian Association of Industrial Hygienists (AIDII) was founded in Milan by Academics working at the Clinica del Lavoro, one of the oldest institutions for work prevention in the world and within the most prolific institutes in the world on Occupational Medicine and Industrial Hygiene. AIDII was founded as a scientific association with the primary purpose of promoting the development, deepening and dissemination of Industrial Hygiene, the scientific discipline aimed at identifying, assessing and controlling chemical, physical and biological risk factors (as well as transversal risks) either inside or outside the workplace, which can alter the health and well-being status of workers and/or the general population, for the purpose of effective prevention and protection of human health. Over the decades, the activities of AIDII have evolved to meet some of the current needs and challenges, while remaining consistent with the basics set by the founders.
Key words: Industrial hygiene, occupational hygiene, environmental hygiene, occupational medicine, history
Abstract
L’Associazione Italiani degli Igienisti Industriali (AIDII) è stata fondata nel 1969, da esperti accademici del settore operanti presso la Clinica del Lavoro di Milano, una delle più antiche e scientificamente e culturalmente prolifiche istituzioni di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale a livello mondiale. AIDII nasce come associazione scientifica avente lo scopo primo di promuovere lo sviluppo, l’approfondimento e la divulgazione dell’igiene industriale, ovvero di quella disciplina scientifica volta ad individuare, valutare e controllare i fattori di rischio chimico, fisico e biologico, nonché fattori di rischio trasversali, presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro, in grado di alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e/o della popolazione generale, ai fini di una efficace prevenzione, protezione e tutela della salute umana. Nel corso dei decenni, le attività di AIDII si sono evolute per rispondere alle esigenze e alle sfide poste dall’evoluzione del mondo del lavoro, rimanendo però coerenti agli insegnamenti di base posti dai maestri della disciplina, che hanno contribuito allo sviluppo della Clinica del Lavoro di Milano e, contestualmente, dell’Associazione stessa.
La Clinica del Lavoro di Milano
Come ricordato negli altri contributi a questo volume e come precedentemente analizzato nel dettaglio in Riva et al. (3), Luigi Devoto, il fondatore della Clinica del Lavoro di Milano, nel 1910 ebbe l’idea pioneristica di creare un laboratorio di chimica nel suo Istituto, sostenendone l’importanza e l’assoluta rilevanza nello studio della patogenesi e del trattamento delle malattie professionali. Nei primi decenni del XX secolo, il laboratorio si concentrò dunque sulle intossicazioni causate dai metalli pesanti e, in particolare, dell’intossicazione da piombo. Nel 1948, il nuovo direttore della Clinica, Enrico C. Vigliani, istituì il primo laboratorio di igiene industriale in Italia, negli anni del boom economico. In questo periodo, il laboratorio di igiene industriale, la cui Direzione fu affidata a Nicola Zurlo, sviluppò ricerche in diversi campi, come esposizione e silice e silicosi, esposizione a polveri organiche e di miniera, insetticidi organofosforici ecc., sviluppando al contempo il campo della tossicologia del lavoro ed ottenendo risultati estremamente rilevanti, contribuendo pertanto in modo significativo allo sviluppo della disciplina. È importante inoltre menzionare l’importanza degli studi di Gianmarco Cavagna sulla patogenesi della bissinosi e il ruolo eziologico delle endotossine. In quegli anni, i settori produttivi primario e secondario (l’agricoltura e l’industria) rappresentavano i principali campi di interesse per igienisti industriali e tossicologi. Negli anni ‘80 e ‘90, accanto alle classiche problematiche occupazionali, il laboratorio ha iniziato a occuparsi della tossicologia ambientale, concentrandosi sugli effetti delle sostanze tossiche ubiquitarie tipiche del settore terziario e del terziario avanzato (ad esempio benzene e idrocarburi policiclici aromatici derivanti da emissioni dovute al traffico veicolare) sulla popolazione generale e viene quindi studiato e approfondito il nuovo problema della qualità dell’aria indoor.
In quegli anni, grazie al lavoro di Antonio Colombi, Marco Maroni, Mario Patroni e Gianfranco Peruzzo, coordinati da Vito Foà molti altri tecnici e ricercatori vennero coinvolti nelle attività di ricerca nel settore dell’Igiene e della Tossicologia Occupazionale ed Ambientale. Nel complesso dunque, la storia dei laboratori di igiene industriale e di tossicologia della Clinica del Lavoro di Milano mostra un esempio dello sviluppo di queste discipline nel corso del secolo scorso, proiettate verso le attuali sfide definite in materia.
Il ruolo della Clinica del Lavoro nella Fondazione di AIDII
Al boom economico degli anni ’60, con la moltiplicazione della forza lavoro nell’industria, le innovazioni tecnologiche e la trasformazione dell’organizzazione del lavoro, fanno progressivamente seguito la presa di coscienza delle forze sindacali circa i problemi di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e la elaborazione di modelli originali di analisi dei fattori di rischio. Emerge in modo sempre più diffuso l’esigenza di nuove modalità di indagine negli ambienti di lavoro con la partecipazione attiva dei lavoratori, dando valore agli elementi di “soggettività” nella valutazione di rischi, danni, e nell’elaborazione di possibili soluzioni di miglioramento. Tutti questi elementi hanno costituito uno stimolo al rinnovamento per gli Istituti di Medicina del Lavoro dell’epoca e ad introdurre negli stessi un primo patrimonio di uomini e strumenti per dare deciso avvio anche all’Igiene Industriale, disciplina emergente in Italia e già praticata da tempo in altri stati ad elevata Industrializzazione, come Stati Uniti d’America e Regno Unito ove si erano nel frattempo costituite l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH – 1946, precedentemente era The Independent National Conference of Governmental Industrial Hygienists - NCGIH - fondata il 27 Giugno del 1938, in Washington, D.C.) (5) e la British Occupational Hygiene Society (BOHS - 1953) (6).
Nell’anno accademico1968-1969, la Clinica del Lavoro di Milano organizza, in collaborazione con il Politecnico di Milano, il corso di “Cultura in Igiene Industriale ed Ergonomia” che costituisce un cruciale momento di incontro tra gli operatori motivati a dare vita e impulso alla Disciplina dell’Igiene Industriale e della Medicina del Lavoro, entrambe intrinsecamente interconnesse e con spiccate caratteristiche pluridisciplinari. In quegli anni, presso la Clinica del Lavoro di Milano, accanto alle attività di clinica e ricerca medica, si svolgevano già e da più di 10 anni attività riferibili all’Igiene Industriale e in parte alla Tossicologia ed Ergonomia: monitoraggio ambientale, monitoraggio biologico, messa a punto di tecniche analitiche specifiche, messa a punto e sperimentazione di strumenti di campionamento, sviluppo di camere di esposizione a concentrazione nota di sostanza da somministrare per via inalatoria alle cavie, messa a punto di un telefrequenzimetro per misurare il gettito cardiaco di soggetti che lavoravano in ambienti termici estremi, modifica del globotermometro di Vernon. La Clinica del Lavoro di Milano rappresentava inoltre un punto di raccordo delle esperienze culturali, scientifiche, sindacali e costituiva il luogo più naturale per dare vita ad una associazione scientifica di Igiene Industriale.
Nella primavera 1969 si svolgono numerose riunioni con esperti di diversa formazione culturale e affiliazione istituzionale, interessate a contribuire alla fondazione di una associazione scientifica dedicata alle problematiche emergenti dell’Igiene Industriale, di cui si andavano elaborando obiettivi, ipotesi di strutturazione e statuto. Il risultato di queste riunioni e del fermento che si sviluppò intorno alla Disciplina, è rappresentato dalla fondazione dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII), che avviene a Milano, il 7 ottobre del 1969 (figura 1). L’assemblea costituente si tiene presso la Clinica del Lavoro dell’Università di Milano, che è stata il centro propulsore dell’iniziativa. Partecipano all’assemblea costituente 85 persone (ingegneri, medici, chimici, fisici, tecnici) operanti presso strutture pubbliche e private. I membri fondatori dell’associazione sono Luigi Metrico, Fulco Douglas Scotti, Gaetano Maria Fara, Angela Maria Griffini e Nicola Zurlo. A comporre il primo consiglio direttivo vengono nominati Enrico Vigliani (in qualità di Presidente), allora Direttore della Clinica del Lavoro, e Nicola Zurlo (in qualità di Segretario-Tesoriere), allora responsabile del Laboratorio di Igiene Industriale della Clinica del Lavoro. Zurlo succede quindi a Vigliani in qualità di Presidente per tre mandati (1975-1982), contribuendo a garantire continuità nel rapporto tra Clinica del Lavoro e AIDII.
Figura 1.

Dettagli dell’atto costitutivo dell’Associazione italiana degli Igienisti Industriali (AIDII)
Figure 1 - Details of the constitutive Act of the Italian Association of Industrial Hygienists (AIDII)
Diverse sono le figure che hanno lavorato in Clinica del Lavoro e che a diverso titolo hanno contribuito allo sviluppo di AIDII: tra queste ricordiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo Luigi Metrico, Luigi Pozzoli, Carlo Sala, il Dott. Belvedere, la Dott.ssa Andreoletti ed molti altri ancora che in questa sede potrebbero sfuggire alla memoria degli autori.
La nomina a Presidente AIDII di Gianfranco Peruzzo (1991-1994) e di Domenico Maria Cavallo (2015-2018), oltre che la nomina nel Consiglio Direttivo AIDII di numerosi altri Igienisti provenienti dalla Clinica del Lavoro di Milano, hanno nel tempo contribuito a rinnovare il legame tra Clinica del Lavoro e AIDII nei decenni successivi, e fino ai giorni nostri.
Appare dunque evidente lo stretto legame tra l’Associazione e la Clinica del Lavoro, non solo per quanto concerne la partecipazione sin dalla fondazione di AIDII di molti dei migliori ricercatori ed esperti della Disciplina, ma anche per la comunità di intenti che AIDII e la Clinica del Lavoro perseguivano e che ancora ancora oggi rappresentano il fulcro delle numerose attività scientifiche condotte in ambito di Igiene Industriale e Tossicologia nella Medicina del Lavoro.
Storia dell’Igiene Industriale: l’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali
Nel contesto di fine anni ‘60, estremamente fertile e prolifico dal punto di vista culturale e scientifico, AIDII nasce come associazione scientifica avente lo scopo primo di “promuovere lo sviluppo, l’approfondimento e la divulgazione dell’igiene industriale, ovvero di quella disciplina scientifica volta ad individuare, valutare e controllare i fattori di rischio chimico, fisico e biologico, nonché fattori di rischio trasversali, presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro, che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e/o della popolazione generale, ai fini di una efficace prevenzione, protezione e tutela della salute umana”. All’epoca della fondazione di AIDII, gli Istituti Universitari di Medicina del Lavoro sono ancora i depositari pressoché esclusivi del Sapere sulle malattie professionali e delle correlazioni con le condizioni degli ambienti di lavoro che le generano. Ad essi fanno riferimento anche organismi istituzionali centralizzati per la prevenzione degli infortuni quali l’ENPI o assicurativi quali l’INAIL o di controllo quali l’Ispettorato del Lavoro. A differenza di altre nazioni industrialmente avanzate, in Italia non esistono ancora insegnamenti di Igiene Industriale né indagini ambientali strutturate negli ambienti di lavoro. Solo alcune grandi aziende nazionali cominciano a strutturare nuclei di Igiene Industriale presso i servizi medici aziendali o all’interno di strutture tecniche aziendali o in collaborazione con istituti universitari, come nel caso del laboratorio di Igiene Industriale Montecatini istituito presso la Clinica del Lavoro di Milano.
Le attività di formazione e le attività congressuali costituiscono una costante dell’AIDII, che organizza numerosi eventi, tra i quali si possono ricordare: il Simposio sul rumore nell’industria (1970), la Tavola rotonda “i compiti dell’Igienista Industriale nell’ambiente di lavoro” (1974), i corsi di formazione per i soci e personale esterno di istituti pubblici e società private realizzati a partire dal 1974, il Convegno “Le polveri pneumoconiogene nell’ambiente di lavoro” (1975), il Convegno “Il microclima come problema di Igiene Industriale” (1975); i Congressi Nazionali di Igiene Industriale che si svolgono annualmente, a partire dal 1977 (figura 2), in località diverse; giornate scientifiche - spesso organizzate contestualmente al congresso nazionale, con finalità anche di aggiornamento dei soci - su temi di attualità nel campo dell'Igiene Industriale, a partire dal 1983. L’attività di AIDII si organizza quindi nelle Sezioni Territoriali il cui ruolo diviene sempre più importante anche nell’organizzare convegni monotematici su temi di attualità che costituiscono un elemento propulsivo per l’associazione. Occorre inoltre ricordare l’organizzazione di un congresso a livello internazionale (International Congress on Industrial Hygiene, Roma, 5-9 ottobre 1986) e a livello europeo (European Industrial Hygiene Conference: Strategies in Industrial Hygiene and Environmental Protection, Milano, 4-7 Novembre 1990) e del congresso internazionale IOHA del 2010 a Roma (28 settembre – 1 ottobre).
Figura 2.

Atti del Primo Congresso Nazionale dell’Associazione italiana degli Igienisti Industriali (Milano, 1977)
Figure 2 - Proceedings of the First National Congress of the Italian Association of the Industrial Hygienists (Milan, 1977)
L’attività di formazione rivolta ai soci e ad esterni è stata curata fin dai primi anni e continua tuttora con corsi mirati ad argomenti generali e all’approfondimento di temi specifici. L’Igiene Industriale rientra da tempo nei corsi universitari presso dipartimenti medici e scientifici e impegna docenti che hanno avuto ruoli importanti nell’AIDII. Le aree di conoscenza che rientrano nel percorso formativo sono state definite in un convegno dei primi anni ‘90 a Ginevra con il contributo delle associazioni nazionali: tossicologia, fisiologia, ergonomia, effetti sulla salute legati al lavoro, salute pubblica, protezione dell’ambiente, comunicazione, fattori psicosociali, norme e leggi, analisi dei rischi, principi di ventilazione industriale, fondamenti di tecnologia.
L’AIDII si dota inoltre di una propria rivista periodica, il “Giornale degli Igienisti Industriali”, a partire dalla fine del 1976, la cui pubblicazione, sotto forme editoriali diverse, continua fino ad oggi con la denominazione Italian Journal of Occupational and Environmental Hygiene (IJOEHY). Nell’ambito dell’attività editoriale sono state inoltre prodotte, in tempi successivi, alcune monografie con un taglio di guide per affrontare alcuni problemi ricorrenti nell’attività quotidiana, come ad esempio l’impostazione di una indagine per la valutazione dell’esposizione occupazionale, la strategia di campionamento e la valutazione statistica dei dati per la verifica della conformità rispetto ai valori limite di esposizione, la valutazione dei sistemi di ventilazione e aspirazione, la valutazione dei campi elettromagnetici. Storicamente AIDII ha curato la traduzione italiana dei TLV dell’ACGIH distribuita contestualmente al Giornale a tutti i soci (figura 3). A questo proposito, già nel 1975 l’AIDII e la SIMLII avevano proposto una tabella di “Valori Limite Ponderati (VLP) degli inquinanti chimici e particolato degli ambienti di lavoro” (4) prendendo in considerazione 185 sostanze sulla base della stessa metodologia utilizzata dall’ACGIH e tenendo conto dell’esperienza maturata attraverso le indagini nelle aziende italiane e di quanto emerso nel convegno tenutosi a Milano del 1973: “I limiti massimi ammissibili (MAC) degli agenti nocivi nell’industria”.
Figura 3.
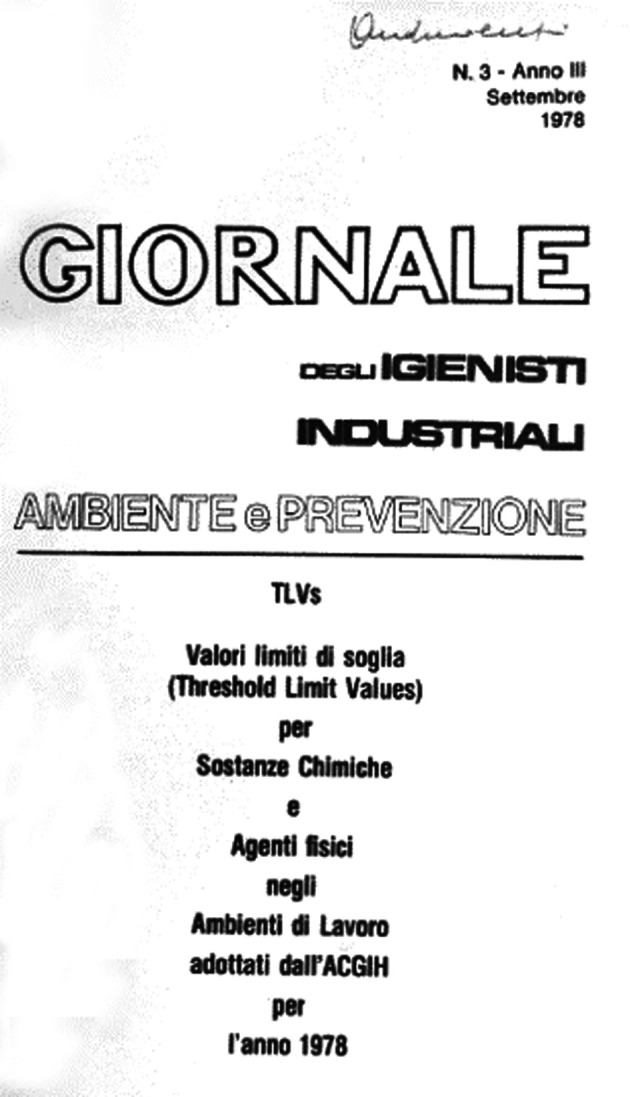
Traduzione Italiana del volume dei Threshold Limit Values (TLV) del 1978 , a cura di AIDII
Figure 3 - Italian translation of the Threshold Limit Values (TLVs), edited by AIDII (1978)
A partire dai primi anni ’90 AIDII intensifica e favorisce il mantenimento di rapporti con le società che operano in campi paralleli, come la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), la Società Italiana di Tossicologia (SITOX), la Società Italiana di Ergonomia (SIE), l’Associazione Italiana di Acustica (AIA), la Società Italiana Valori di Riferimento (SIVR), l’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (già Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza AIAS), la Società Italiana di Aerosol (IAS).
AIDII ha inoltre partecipato alla costituzione della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), di cui è stata fondatrice e parte integrante e attiva fino al 2009.
Evoluzione del ruolo dell’Igienista Industriale
L’Igiene Industriale, in quanto parte integrante della declaratoria ministeriale del Settore Scientifico Disciplinare a livello Accademico, è da sempre integrata e quindi strettamente interconnessa con la Medicina del Lavoro. Appare quindi evidente l’opportunità di operare in modo complementare e sinergico tra la componente di valutazione dell’esposizione e la componente clinica anche come elemento di prevenzione, formazione e crescita culturale.
Le attività prevalenti sono inizialmente incentrate sulla messa a punto di metodiche per il campionamento e analisi da applicare al monitoraggio ambientale e biologico e sulle indagini nei reparti di lavoro con l’obiettivo di valutare l’esposizione degli addetti ad agenti chimici e fisici, il rispetto dei valori limite di esposizione, l’efficienza ed efficacia degli interventi di bonifica, la necessità di stabilire programmi di monitoraggio periodici. La ricerca applicata e la formazione sono attività complementari che assumono importanza crescente. Dagli inizi degli anni ‘70 e durante l’intero decennio vengono create o potenziate strutture di Igiene Industriale all’interno di numerosi istituti pubblici (Istituti universitari di Medicina del Lavoro, Servizi ospedalieri di Medicina del Lavoro, Istituti scientifici di ricovero e cura, ENPI, INAIL, ISS, Laboratori di igiene e profilassi, etc.), oltre che Servizi Aziendali, Consorzi sanitari di zona, e in strutture private.
Ruolo e funzioni dell’Igiene Industriale trovano una loro definizione compiuta e condivisa agli inizi degli anni ’90, anche a seguito del confronto tra esperti nell’ambito di consessi a livello internazionale: “L’Igienista Industriale ha il compito di individuare, valutare e mantenere sotto controllo, ai fini della prevenzione e della bonifica, i fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dalla attività industriale, presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita, che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione”. L’ambiente di lavoro costituisce comunque il campo sperimentale principale dove è possibile approfondire e affinare le conoscenze, mediante:
approfondita conoscenza del ciclo di produzione sotto il profilo dei possibili rischi per i lavoratori e dei possibili impatti esterni, per formulare il protocollo di indagine, valutare l’esposizione ed eventualmente suggerire provvedimenti per la riduzione dell’esposizione attraverso la modifica dei processi, delle mansioni, dei sistemi di ventilazione generale di trattamento dell’aria, di aspirazione e abbattimento degli inquinanti.
lavoro in comune e scambio di informazioni con altre professionalità del campo della prevenzione
interpretazione e discussione dei risultati di tutte le fasi di indagine
validazione in campo di nuove tecniche e strumenti di campionamento
valutazione e validazione di modelli di risk assessment
L’Igienista Industriale assume progressivamente un ruolo complementare sempre più importante alle figure di Medico del Lavoro e di addetto alla sicurezza. L’attenzione crescente ai problemi dell’ambiente, specialmente in questi ultimi decenni, amplia il campo di attività all’inquinamento dell’atmosfera, delle acque, del suolo, alla qualità dell’ambiente indoor, ai rischi di incidenti rilevanti, alla valutazione di impatto ambientale e sanitario. Il campo di indagine si è inoltre progressivamente espanso anche a causa della crescente terziarizzazione dell’attività produttiva: ha quindi assunto maggiore importanza l’ambiente indoor, ormai sede di gran parte dell’attività lavorativa. con una contestuale diminuzione di attività tradizionalmente considerate a rischio, per il trasferimento di produzioni impattanti in paesi emergenti e a causa della globalizzazione dell’economia di mercato. È stato inoltre necessario, negli ultimi decenni, adeguare le conoscenze e gli strumenti logici e pratici di indagine all’evoluzione delle tecnologie produttive (tra cui si citano a titolo di esempio le nanotecnologie, la sintesi e commercializzazione di nuove sostanze e formulati, l’introduzione di nuove tecnologie e tecniche di produzione e di nuove tecnologie per l’abbattimento degli inquinanti), per evidenziare e mettere sotto controllo i rischi emergenti negli ambienti di vita e di lavoro.
La necessità di certificare la figura dell’igienista industriale che ha acquisito specifica formazione trova il proprio sbocco con la fondazione, nel dicembre 1986, dell’Istituto per la Certificazione degli Igienisti Industriali (ICII) con proprio consiglio direttivo e gruppo di esperti che prepara ed aggiorna le domande di esame. L’Istituto si dota inoltre di un proprio codice etico.
Nel 2004 avviene la fondazione dell’Istituto per la Certificazione Professionale per le Figure della Prevenzione (ICFP) che ha permesso di compiere un ulteriore passo verso la certificazione della figura professionale dell’Igienista Industriale, fissando i campi di competenza necessari a caratterizzare il professionista che deve individuare, valutare, controllare l’insieme dei fattori di rischio che hanno origine dall’attività lavorativa e interessano il lavoratore, lo stesso ambiente di lavoro, ivi compreso quello indoor e l’ambiente esterno, rispettando quanto previsto da un aggiornato codice deontologico. Nel gennaio del 2009 è stata superata l’ultima fase del percorso di certificazione previsto dalla ISO 17024 per il riconoscimento da parte del SINCERT (oggi Accredia) che ha valore per tutto il territorio europeo, recentemente esteso anche a livello internazionale grazie al riconoscimento da parte del National Accreditation Recognition Committee (NAR) dell’International Occupational Hygiene Association (2).
Attualmente, il riferimento legislativo per l’inquadramento della figura professionale dell’Igienista Industriale è la Legge 4 del 2013 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate (1). Inoltre, la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 (7) e la Norma UNI 11711:2018 (8) richiedono una valutazione delle conoscenze, abilità e competenze basata su criteri oggettivi, la gestione dei conflitti di interesse a garanzia dell’imparzialità e obiettività per il rilascio della certificazione della figura professionale di Igienista Industriale, criteri applicati nel nuovo schema di certificazione ICFP. È bene ricordare che attualmente la normativa distingue, oltre al profilo dell’igienista industriale base, i seguenti due profili specialistici, benché essi non siano separabili in senso assoluto o incompatibili tra loro: (i) igienista industriale specializzato nel campo degli agenti chimici e biologici; (ii) igienista industriale specializzato nel campo degli agenti fisici. Questi due profili sono a loro volta articolati in 2 livelli (esperto e senior). L’igienista industriale deve dunque conoscere e sapere applicare: le metodologie di verifica e controllo della generazione e propagazione degli agenti di rischio, le metodologie di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione umana oltre che le tecniche di mitigazione dei rischi stessi, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici degli interventi che per quanto riguarda gli aspetti legati l’organizzazione del lavoro ed a tutte le misure gestionali, ivi compresa la formazione e l’addestramento.
Conclusioni
La storia della Clinica del Lavoro e dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali sono reciprocamente interconnesse e rispecchiano l’evoluzione e lo sviluppo dell’igiene industriale e della tossicologia occupazionale e ambientale a livello mondiale, rappresentando nel passato - e continuando a essere - un elemento di riferimento nazionale e internazionale per la disciplina. Nel corso dei decenni, le attività di della Clinica del Lavoro e di AIDII si sono evolute per rispondere alle esigenze e alle sfide poste dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e del mondo del lavoro, nel solco degli insegnamenti posti dai maestri della disciplina.
Gli autori non hanno dichiarato alcun potenziale conflitto di interesse in relazione alle materie trattate nell’articolo
Bibliografia
- 1.Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate (13G00021) (GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013) [Google Scholar]
- 2. National Accreditation Recognition (NAR) of the International Occupational Hygiene Association (IOHA). Recognised National Accreditation Schemes Disponibile online all'indirizzo: https://ioha.net/wp-content/uploads/2018/08/Summary-of-Schemes-Timetable-Oct-16.pdf (ultimo accesso il 05/11/2019) [Google Scholar]
- 3.Riva MA, Belingheri M, Fustinoni S. The contribution of the Clinica del Lavoro of Milan to the development of industrial hygiene and toxicology in the twentieth century. Arch. Environ Occup Heal. 2019;74:30–41. doi: 10.1080/19338244.2018.1535482. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
- 4.Società Italiana di Medicina del Lavoro e Associazione Italiana degli Igienisti Industriali. Valori Limite Ponderati degli inquinanti chimici e particolati degli ambienti di lavoro per il 1975. Med Lav. 1975;66(4):361–371. [PubMed] [Google Scholar]
- 5.The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) About ACGIH® disponibile online all'indirizzo: https://www.acgih.org/about-us/aboutacgih. (ultimo accesso il 05-11-2019) [Google Scholar]
- 6.The British Occupational Hygiene Society (BOHS) About Us. disponibile online all'indirizzo: http://www.bohs.org/about-us/ (ultimo accesso il 05-11-2019) [Google Scholar]
- 7.UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone [Google Scholar]
- 8.UNI 11711:2018 Attività professionali non regolamentate - Igienista industriale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza [Google Scholar]


